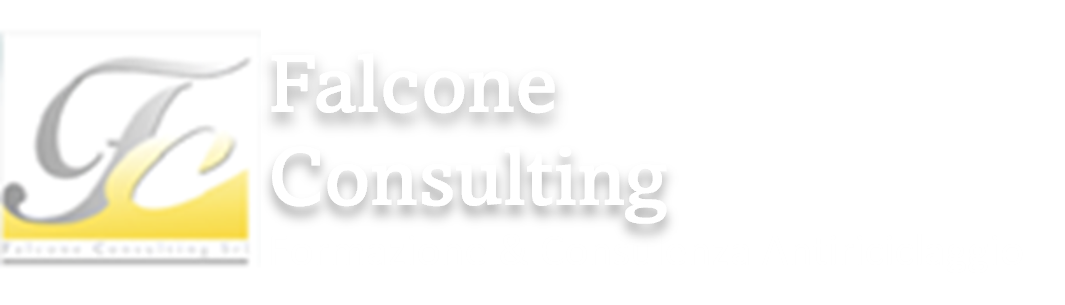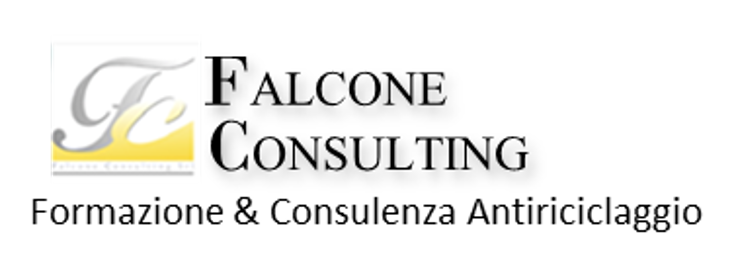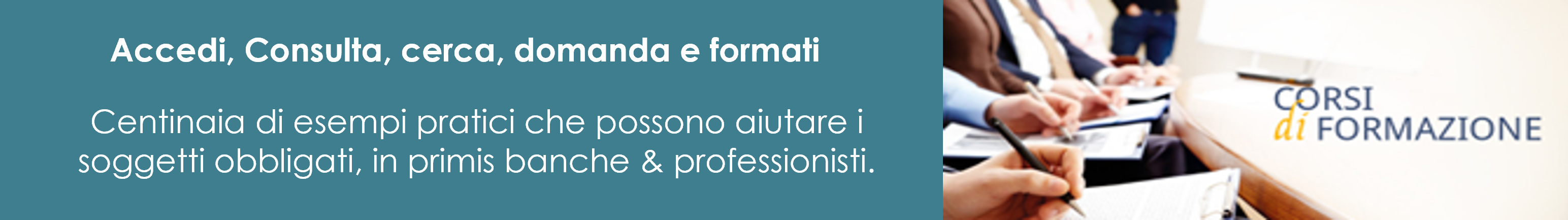Da un testamento autentico, riporto:
“”Testamento di me medesimo malato tisico[1] lucido di mente, scritto a mano contro mia moglie Maria Cannavacciuolo maritata Buonomo Gennaro che sarei io.
Se morirebbe prima mia moglie di me sarei grato a San Gennaro a ceri e fiori finacché campo. Ma lei si è sempre curata bene e schiatta di salute alla faccia mia che non ce speranza, io credo.
Approfitto della controra che stà stravaccata sopralletto per scrivere nascostamente nel gabinetto su carta tipo igienica[2] il mio lascito testamento di robbe poche ma stentate, col sudore della fronte per tutta una vita onesta ma sfortunata. Che se si sveglia sono mazzate.
Non avendo la infamona fatti i figli perché è arida di panza e di cuore[3], lascio il basso di abitazione a mio nipote Libberato figlio di mio fratello Vittorino.
A mia nipote Italia, sempre figlia di Vittorino, lascio per dote la mobilia con la biancheria di correto, l’anello mio, la catenina e il curniciello[4] della buonanima del nonno.
Quando sarò morto dovete cercare il mio testamento qui presente dietro all’armadio. Se non lo cercate dietro all’armadio non lo trovate, e allora è inutile che lo cercate[5].
[1] Malato di tisi o rinsecchito per altro male
[2] Il testamento è scritto su un foglio di carta paglia usata per incartare
[3] Cioè la moglie è sterile, ma lo dice con cattiveria
[4] E’ un piccolo corno di corallo cui si attribuiscono poteri antifattura
[5] In genere il testatore, dopo aver ricopiato in bella copia il suo olografo, lo ripone in un luogo sicuro. Dopo la sua morte, chiunque lo rinviene è tenuto per legge a consegnarlo ad un notaio per la sua pubblicazione. Per evitare però che il rischio che il nascondiglio prescelto si riveli fin troppo sicuro, o che un erede malizioso lo faccia sparire, oppure che un accidente lo distrugga, il testatore può consegnarlo egli stesso ad un notaio di fiducia. Dopo la sua morte, il notaio provvederà ad informarne gli eredi e a renderne pubblico il contenuto a mezzo di un apposito verbale.